Non mi piace non sapere. L’ossessione dell’ottenere tutte le informazioni disponibili
 Come si comporta la nostra mente di fronte all’incertezza? A prima vista non sembra essere fatta per sentirsi a proprio agio e per molti di noi il confronto potrebbe rivelarsi molto più faticoso che per altri, generando una vera e propria “intolleranza” alle situazioni incerte.
Come si comporta la nostra mente di fronte all’incertezza? A prima vista non sembra essere fatta per sentirsi a proprio agio e per molti di noi il confronto potrebbe rivelarsi molto più faticoso che per altri, generando una vera e propria “intolleranza” alle situazioni incerte.
Scopriamone il perchè?
Il termine “intolleranza all’incertezza” è stato introdotto per la prima volta negli anni ‘90 e si riferisce a “una disposizione cognitiva negativa nei confronti di situazioni percepite come ambigue e poco prevedibili. Si tratta dell’incapacità di sopportare la semplice, minima esistenza di un rischio ed è una componente possibile dell’ansia.
Può essere ulteriormente spiegata come l’incapacità di sopportare uno stato emotivo negativo, innescato dalla percepita assenza di informazioni salienti o sufficienti su eventi incerti. Sono eventi incerti tutte quelle situazioni che potrebbero avere un esito positivo, neutro o negativo, ma che non si sono ancora verificate.
L’intolleranza all’incertezza ha radici sia genetiche che ambientali. Gli studi hanno evidenziato sia componenti genetiche che possano predisporre a sviluppare tale aspetto, sia esperienze di vita, come un’educazione iperprotettiva o traumi che possono amplificarne l’impatto.
Le persone con un’elevata intolleranza all’incertezza tendono sempre a percepire l’ambiguità come minacciosa (sovrastimano la probabilità che si verifichi un evento negativo), sviluppando pensieri negativi e strategie non funzionali per affrontarla, ma anche a valutare di non possedere sufficienti abilità di gestione, adeguate a fronteggiare situazioni improvvise, o, ancora, a ritenere che gli eventi incerti debbano essere evitati, indipendentemente dalla reale possibilità che possano verificarsi.
In altri termini, la paura dell’incertezza deriverebbe dall’assunzione ansiogena che dalla situazione incerta derivi necessariamente un fallimento.
Secondo le teorie psicologiche, l’intolleranza all’incertezza costituisce un aspetto centrale dei disturbi d’ansia, congiuntamente ad altri aspetti come la sovrastima della minaccia e il perfezionismo patologico. La letteratura medica la considera coinvolta nello sviluppo e nel mantenimento di diversi disturbi psicologici quali il disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo d’ansia generalizzata, disturbo di panico, disturbo d’ansia sociale e depressione.
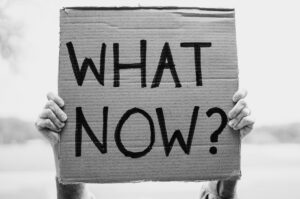 Nel momento in cui le nostre esperienze e conoscenze non sono sufficienti a rendere gli eventi futuri controllabili e prevedibili, ognuno di noi mette in atto una serie di strategie. Alcune di queste si rivelano funzionali e adattive, finalizzate a ridurre (anche se talvolta in modo illusorio) l’incertezza che caratterizza le situazioni di vita, altre, al contrario, innescano dei veri e propri effetti psicopatologici.
Nel momento in cui le nostre esperienze e conoscenze non sono sufficienti a rendere gli eventi futuri controllabili e prevedibili, ognuno di noi mette in atto una serie di strategie. Alcune di queste si rivelano funzionali e adattive, finalizzate a ridurre (anche se talvolta in modo illusorio) l’incertezza che caratterizza le situazioni di vita, altre, al contrario, innescano dei veri e propri effetti psicopatologici.
Sarebbero coinvolte sia strategie attive volte a eliminarla (ad esempio, azioni dirette, ricerca di informazioni, mantenimento della vigilanza), sia strategie di controllo delle emozioni finalizzate a ridurre al minimo il disagio emotivo associato all’incertezza .Ognuno può strutturare strategie o comportamenti differenti, che hanno l’obiettivo comune di ridurre la sofferenza.
Sono fondamentalmente cinque le individuate categorie di risposte comportamentali che possiamo intraprendere per gestire l’incertezza:
- Ipercoinvolgimento
- Disimpegno
- Impulsività
- Procrastinazione
- “Flip-flop” (oscillazione)
L’iper-coinvolgimento è una strategia attiva , motivata dalla necessità di incrementare la certezza, include vari comportamenti volti ad aumentare la convinzione, come ad esempio la ricerca eccessiva d’informazioni o continuare a ipotizzare possibili esiti futuri e relative azioni da programmare. Esemplificativo di questo atteggiamento è stato, nel periodo del covid-19 l’eccessiva ricerca di notizie sull’evoluzione del virus attuata tramite il costante monitoraggio di pagine internet/siti web/social media/ chat-gpt e la continua visione di telegiornali e trasmissioni televisive sull’argomento, al fine di riprodurre più e più volte nella propria mente le informazioni acquisite e rimuginare su possibili conseguenze. Tutti i comportamenti sovra elencati sono in genere motivati da una (illusoria) percezione di incrementato controllo sulla situazione, tuttavia le principali conseguenze negative di questo approccio consistono solo nell’ulteriore incremento della sensazione di incertezza.
 Il disimpegno implica la messa in atto di comportamenti finalizzati a evitare future situazioni incerte ed a non provare emozioni negative nel breve termine, consentendo alla persona di sentirsi rassicurata. Tuttavia, è sempre possibile che, in qualsiasi momento, non vi sia più la possibilità di evitare completamente le situazioni ed in tal caso le emozioni saranno particolarmente intense e persistenti. La messa in atto di tale condotta viene rinforzata negativamente dalla riduzione dell’ansia temporanea, tuttavia l’evitamento impedisce alla persona di rielaborare cognitivamente l’esperienza emozionale e di sperimentare l’assenza del collegamento tra stimolo incerto e conseguenze avverse.
Il disimpegno implica la messa in atto di comportamenti finalizzati a evitare future situazioni incerte ed a non provare emozioni negative nel breve termine, consentendo alla persona di sentirsi rassicurata. Tuttavia, è sempre possibile che, in qualsiasi momento, non vi sia più la possibilità di evitare completamente le situazioni ed in tal caso le emozioni saranno particolarmente intense e persistenti. La messa in atto di tale condotta viene rinforzata negativamente dalla riduzione dell’ansia temporanea, tuttavia l’evitamento impedisce alla persona di rielaborare cognitivamente l’esperienza emozionale e di sperimentare l’assenza del collegamento tra stimolo incerto e conseguenze avverse.
L’impulsività prevede invece l’agire immediato senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni, con l’obiettivo di eliminare immediatamente l’incertezza. Questa modalità comprende sia il fare la prima cosa che ci “passa per la testa”, per alleviare illusoriamente e temporaneamente il disagio causato dall’incertezza.
Il “flip-flop” (oscillazione) consiste nel continuo e repentino cambiamento di strategia, per cui la persona oscilla tra la ricerca della certezza e l’evitamento dell’incertezza.
È opportuno evidenziare come ciascuna di queste strategie, di per sé, possa essere funzionale e adattiva; una strategia diventa invece disfunzionale nel momento in cui giunge ad essere impiegata in modo rigido e convenzionale. Pertanto, è l’utilizzo fisso e inflessibile di tali strategie a rappresentare un potenziale fattore di rischio per lo sviluppo di un disagio psicologico e, a lungo termine, di una psicopatologia.
I professionisti della salute mentale hanno il compito sostanziale di aiutare le persone a comprendere l’importanza di imparare a tollerare l’incertezza: cercare di controllare la realtà, infatti, non costituisce una strategia efficace per la gestione delle emozioni negative, l’esercizio di controllo risulta poco praticabile, se non addirittura assurdo. Il cercare la sicurezza, non farà altro che ridurre ulteriormente la tolleranza dell’incertezza, contribuendo al mantenimento dello stato d’ansia.
Investire nella comprensione e nella gestione dell’incertezza può migliorare significativamente la qualità della vita, promuovendo resilienza e adattabilità; in un mondo in costante cambiamento, imparare a convivere con l’insicurezza non è solo una necessità, ma un’abilità cruciale.
Il nostro cervello è progettato per affrontare l’imprevedibile, abbiamo cioè delle risorse innate che ci permettono di fronteggiare le difficoltà in modo positivo. Se così non fosse alla prima occasione imprevista avremmo avuto la peggio e non saremmo qui a parlarne.
Cosa fare?
Imparare a tollerare l’incertezza implica l’assunzione di una posizione equilibrata e intermedia tra iper-coinvolgimento e disimpegno, guidata dalla conoscenza delle poche ma tuttavia presenti e sufficienti certezze relative.
 Tollerare l’incertezza non garantisce l’assoluta tranquillità, ma potrebbe dare la possibilità di cogliere diverse e nuove opportunità, rispetto all’essere in balia della sensazione di intolleranza.
Tollerare l’incertezza non garantisce l’assoluta tranquillità, ma potrebbe dare la possibilità di cogliere diverse e nuove opportunità, rispetto all’essere in balia della sensazione di intolleranza.
Si tratta di modificare credenze cognitive come: “ciò che è incerto è pericoloso”, sperimentando che ciò che è incerto non significa necessariamente che abbia un esito negativo (la tendenza a produrre previsioni negative e talvolta catastrofiche è effettivamente presente in maggior misura nei soggetti ansiosi che in quelli normali), accettando che “non tutto può essere conosciuto o previsto”, ma si può sperimentare un momento presente sereno, pur sapendo dell’eventualità continua di sorprese, correggendo il punto di vista per cui si tende a mettere su uno stesso piano l’incertezza ed il pessimismo.
La soluzione alla paura dell’incertezza appare allora quella di iniziare a percepire l’incertezza stessa, innanzitutto, come condizione intrinseca, e di conseguenza normale, all’essere umano, la certezza non è un nostro potere e che nessuna condizione della vita umana gode di controllo assoluto.
Si rivela fondamentale nella cura dell’incertezza insegnare alle persone il focalizzarsi sul presente, non per distrarsi dal futuro, ma perché il presente è l’unica dimensione temporale in nostro possesso. L’intolleranza all’incertezza, infatti non va interpretata come paura dell’incomprensibile o dell’imponderabile, quanto, come timore eccessivo per ciò che il futuro riserva.
L’incertezza è importante imparare a tollerarla, entrando in contatto con le nostre emozioni, anche quelle più spiacevoli, senza necessariamente allontanarle, ma per starci dentro, così facendo, l’intensità delle stesse tenderà ad abbassarsi un po’ alla volta.
———————
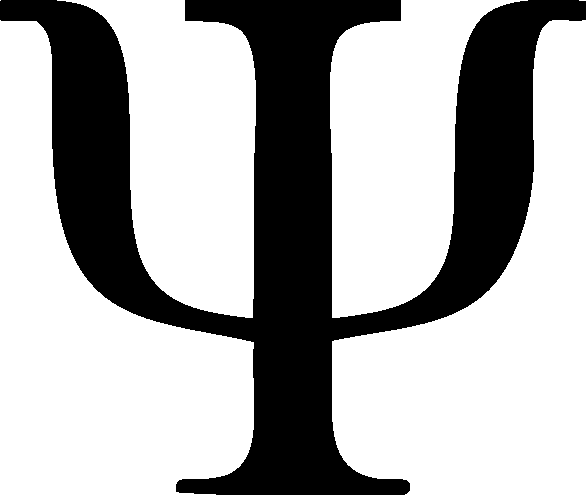

Leave a Comment
(0 Commenti)